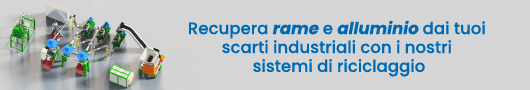Anche quest'anno il Consorzio Italiano Compostatori parteciperà a Ecomondo, appuntamento di grande rilevanza che, ancora una volta, vedrà il CIC protagonista. Appuntamento principale è la XXVII Conferenza nazionale sul compostaggio e sulla digestione anaerobica del mercoledì, per fare il punto sulla filiera del rifiuto organico, uno degli esempi più avanzati e virtuosi di economia circolare a livello europeo. Grazie a una rete impiantistica sempre più fitta e distribuita sul territorio, l'Italia ha saputo infatti valorizzare questa filiera come leva strategica per aumentare l'efficienza di impiego delle matrici organiche, ridurre le emissioni di gas serra, contenere i costi di gestione dei rifiuti, produrre energia rinnovabile e creare valore economico e occupazionale sul territorio. Una sessione plenaria seguita da un approfondimento tecnico all'interno di Ecomondo per sottolineare l'impegno del Consorzio nella definizione dei contenuti del programma fieristico.
In questo contesto, il CIC presenterà anche il suo ambizioso progetto di Urban Carbon Farming. Lanciato lo scorso maggio, questo nuovo concetto mira a portare in città i principi del "carbon farming", solitamente applicati in agricoltura, trasformando il verde urbano in un alleato cruciale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per il benessere dei cittadini, valorizzando il ruolo della città nella transizione ecologica
Abbiamo approfondito con Massimo Centemero, Direttore del CIC, i dettagli di questa iniziativa innovativa. Ecco cosa ci hanno raccontato:
1. Quali sono le principali ambizioni del progetto promosso dal CIC e che ruolo può giocare nella diffusione della cultura del compostaggio e dell'economia circolare tra cittadini, amministrazioni e stakeholder privati?
L'Urban Carbon Farming è un concetto del tutto nuovo, lanciato dal CIC lo scorso maggio, che si propone di portare in città i principi del carbon farming, solitamente utilizzato in agricoltura, ovvero una serie di pratiche agricole e forestali virtuose che prevedono anche l'utilizzo del compost al suolo, per aumentare l'assorbimento di carbonio atmosferico (sotto forma di CO₂) proprio nel suolo e nella biomassa vegetale, contribuendo così alla mitigazione del cambiamento climatico. L'obiettivo è quindi quello di aumentare il benessere dei cittadini e nello stesso tempo aumentare la resilienza delle città nel contrastare i cambiamenti climatici e gli eventi estremi che sempre più frequentemente stanno accadendo. è un obiettivo ambizioso, ma abbiamo a disposizione una risorsa naturale, il compost, che, se valorizzato in modo efficace, può rivelarsi un valido alleato per la protezione dei nostri suoli e della biodiversità delle città, riducendo anche la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento che comportano alti costi ambientali ed economici.
2. Quali città italiane hanno già adottato o stanno sperimentando l'Urban Carbon Farming?
Ad oggi alcune città, riconosciute e premiate dal CIC, hanno applicato il compost in diverse aree cittadine per dare nuova vita agli spazi verdi, intuendo il valore che il compost può portare alla vegetazione urbana e al clima nelle città, ma è bene sottolineare che sono progetti che anticipano l'Urban Carbon Farming e ne colgono soltanto alcuni aspetti, ma non sono stati pensati nel loro complesso in un'ottica di Urban Carbon Farming, in quanto ancora questa idea non esisteva.
3. Esistono dati quantitativi sull'impatto di queste pratiche in termini di CO₂?
Essendo un tema nuovo, non ci sono a disposizione dati quantitativi dell'applicazione di queste pratiche a livello urbano. Teniamo però conto che il quadro di certificazione relativo alle pratiche di Carbon Farming a livello agricolo previsto dal Regolamento Europeo 2024/3012 si basa su risultati quantitativi, anche se questi al momento si scontrano con l'imprevedibilità del comportamento, in termini di carbonio effettivamente sequestrato, nei suoli agricoli diversi per caratteristiche strutturali, situati in diverse zone geografiche climatiche. E' però una buona base di partenza per lo sviluppo di indicatori da applicare anche a livello urbano.
4. Come si traduce operativamente l'approccio dell'Urban Carbon Farming nella gestione quotidiana del verde urbano? Quali sono le pratiche agricole o manutentive più efficaci per massimizzare la cattura di carbonio nei contesti cittadini?
L'Urban Carbon Farming ha lo scopo di portare nelle città i principi fondamentali del carbon farming, ovvero sequestrare il carbonio nel suolo, aumentare la biomassa vegetale, aumentando il verde in città, e rigenerare gli ecosistemi (aumento della biodiversità, protezione del suolo dall'erosione, promozione della salute del suolo) rendendoli più resilienti. Un'attenzione alle tecniche di gestione virtuosa del verde delle nostre città può contribuire alla decarbonizzazione, intesa chiaramente come fenomeno più ampio. A livello urbano molti sono gli ambiti di interventi in cui si possono applicare tecniche di "urban carbon farming, dalla creazione di nuovi spazi verdi e la piantumazione e la cura degli alberi, agli interventi di de-paving per la rimozione della pavimentazione e il ripristino della permeabilità del suolo e alle operazioni di forestazione urbana o alla creazione di barriere alberate. Il compost derivato dalla valorizzazione dei rifiuti organici prodotti nelle città è un alleato imprescindibile in tutte queste operazioni, grazie al suo potere fertilizzante naturale, alla sua capacità di stoccare carbonio nel suolo e migliorare la permeabilità dei terreni, senza dimenticare i benefici ambientali dovuti alla sottrazione di un'elevata quantità di rifiuti che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento.
5. Che ruolo gioca il compost nella strategia, e quali sono le caratteristiche del compost considerato "di qualità"?
Il compost è un fertilizzante naturale derivato dalla trasformazione dei rifiuti organici prodotti dai cittadini. Utilizzare quindi il compost per il rinvigorimento delle aree urbane permette di chiudere il cerchio di cui tanto si parla in ottica di economia circolare: i rifiuti organici domestici che vengono trasformati in una risorsa preziosa per il benessere degli abitanti della città stessa. Perché dobbiamo ricordarci che una città "verde" è più resiliente nei confronti dei cambiamenti climatici, più permeabile, meno soggetta a picchi di temperatura e più capace di catturare anidride carbonica e fissare il carbonio al suolo. La qualità del compost è disciplinata dalla norma nazionale (dal 1998) ed europea (dal 2019) sui fertilizzanti. Tra i fattori che determinano la qualità del compost vogliamo ricordare la qualità della raccolta differenziata dei cittadini: differenziare correttamente i nostri rifiuti organici è un fattore imprescindibile per rendere efficiente tutta la filiera che ha come obiettivo finale il Riciclo, ovvero la produzione di compost.
6. Ci sono linee guida o protocolli tecnici che regolano l'applicazione dell'Urban Carbon Farming nei contesti urbani?
Il concetto di Urban Carbon Farming prende spunto dal Regolamento Europeo 2024/3012 che regolamenta la certificazione degli assorbimenti di Carbonio attraverso diverse pratiche, tra le quali anche il Carbon Farming. Come detto, però, il lato "urbano" non è una pratica espressamente contemplata, ma un'evoluzione concettuale che auspichiamo possa essere presto implementata in maniera più estesa, grazie ad un affinamento dello strumento normativo e alla stretta collaborazione tra tutti gli attori in gioco, quali amministrazioni locali, professionisti del verde, stakeholders e cittadini per poter dare un contributo efficace al benessere complessivo di tutta la comunità.
7. Quale tipo di collaborazione intersettoriale (con agronomi, architetti del verde, urbanisti, aziende di gestione rifiuti) è ritenuta più urgente o strategica per integrare l'Urban Carbon Farming nelle politiche urbanistiche?
Una delle azioni da mettere in atto è la predisposizione di un insieme di regole che stabiliscono i confini delle attività di Urban Carbon Farming e ne possano quindi quantificare i benefici. Un tavolo di lavoro intersettoriale che traduca un'idea in un piano operativo sarebbe una delle opzioni auspicabili per giungere in un breve periodo alla costruzione di "casi studio". Vediamo come ruolo chiave l'interessamento e l'intervento delle istituzioni.
8. Il CIC ha attivato collaborazioni con enti di ricerca o università per monitorare i risultati ambientali?
Il CIC ha lanciato da poco il tema dell'Urban Carbon Farming e si sta attivando per instaurare collaborazioni e partnership per meglio promuovere e gestire questo ambizioso progetto, senza dimenticare anche il monitoraggio degli effetti a breve e lungo termine che la sua applicazione comporta.
9. Come viene comunicato ai cittadini il valore del compost e delle buone pratiche legate all'umido?
Dall'introduzione della raccolta differenziata dell'umido, ormai più di trent'anni fa, sono state diverse le campagne di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini. Purtroppo però, a livello nazionale, ci sono ancora Comuni in cui questa attività non è stata implementata o non viene effettuata in maniera efficace: stimiamo che su 59 milioni di abitanti, circa 52 milioni differenziano in modo efficace la frazione umida, lasciando quindi un buon margine di miglioramento. Come CIC sfruttiamo tutte le occasioni per divulgare le buone pratiche di raccolta e gestione dell'umido, nonché i benefici che la sua applicazione può portare per l'economia e per l'ambiente. Tra le ultime iniziative di comunicazione segnaliamo il positivo riscontro di attenzione che ha avuto il podcast "Dalla terra alla Terra" (realizzato in collaborazione con Chora Media), che descrive con un linguaggio semplice l'intera filiera del riciclo organico, dalla corretta raccolta differenziata agli usi e benefici, ambientali e sociali del compost.
10. Esistono criticità o ostacoli (tecnici, normativi, culturali) che rallentano l'adozione di questo modello?
Al momento non c'è una normativa dedicata, ma negli ultimi anni il legislatore italiano ha promosso iniziative che vanno in questa direzione, come ad esempio il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato a fine 2023 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. il Piano mira a ridurre la vulnerabilità del nostro territorio agli impatti dovuti ai cambiamenti climatici e a migliorare la resilienza, delineando linee guida che, se implementate anche con pratiche di Urban Carbon Farming, possono portare vantaggi ambientali e sociali a lungo termine. Senza dimenticare che anche la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 del MASE prevede interventi sul verde urbano per il ripristino degli ecosistemi, favorendo il rinverdimento urbano e l'introduzione e la diffusione di soluzioni basate sulla natura.
11. L'applicazione del compost urbano comporta rischi legati alla contaminazione del suolo (metalli pesanti, microplastiche, ecc.) e come vengono monitorati o mitigati?
Il compost è un prodotto disciplinato dalla normativa sui fertilizzanti che deve rispettare numerosi criteri per poter essere immesso sul mercato e commercializzato. Tra questi sono naturalmente inclusi requisiti sulle impurità fisiche (quali per esempio plastiche, vetro e metalli) e sui metalli pesanti. Dal 2018 il CIC ha attivato, in collaborazione con la Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro - Alimentari dell'Università di Bologna, una stazione sperimentale per lo sviluppo e la valorizzazione del compost di qualità con l'obiettivo di mettere in risalto i benefici derivanti dall'impiego del compost in pieno campo. I risultati dimostrano che l'applicazione di compost ad alto dosaggio ed alta frequenza non comporta concentrazioni di metalli pesanti nemmeno lontanamente vicine ai valori di soglia di rischio previste dalla normativa nazionale, per cui non ci aspettiamo risultati diversi per le applicazioni in campo urbano. Sui parametri emergenti, tra i quali le microplastiche, in virtù della pervasività e ubiquità di questi elementi si rimarca come anche il CIC partecipa a gruppi di lavoro internazionali per definire i confini, le metodologie analitiche, le soglie e soprattutto le soluzioni che ne limitano l'immissione nell'ambiente.
.jpg)